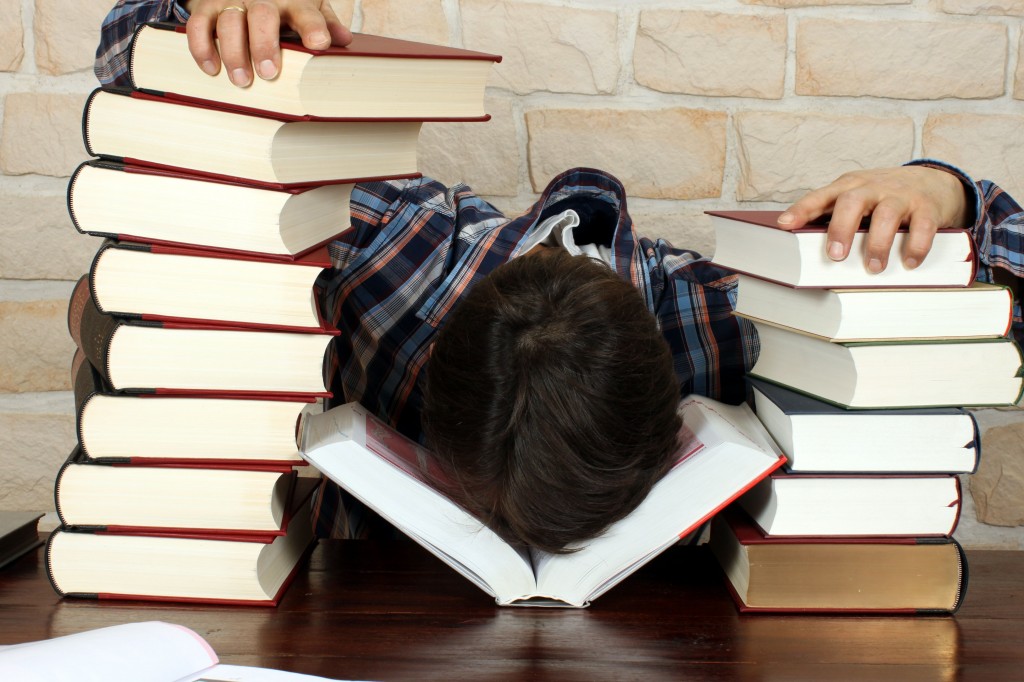
Il benessere organizzativo non nasce dall’assenza di stress, ma da un equilibrio dinamico.
A partire dal periodo pandemico, il mondo del lavoro si è trovato ad affrontare sfide inedite legate a una profonda trasformazione dei modelli organizzativi. Il fatto che molte persone si siano improvvisamente trovate a lavorare da casa ha cambiato drasticamente gli equilibri psicosociali che i lavoratori avevano raggiunto nelle organizzazioni di cui facevano parte; sui social si è cominciato a parlare insistentemente di quiet quitting, ma cosa vuol dire questa espressione?
Il quiet quitting è quella scelta difensiva, spesso lucida e deliberata, di fare solo il minimo indispensabile al lavoro: “staccare la spina” emotivamente, attenersi scrupolosamente a orari e mansioni contrattuali, rinunciare a coinvolgimento proattivo e disponibilità extra. Il lavoratore che adotta questa “strategia” non si licenzia fisicamente, ma smette di investire energie nel miglioramento, nell’innovazione, nella collaborazione tra colleghi, con effetti a cascata sulla performance aziendale e sull’atmosfera del team, oltreché sulla sicurezza complessiva sua e degli altri lavoratori; ma cosa differenzia il quiet quitting da un fenomeno che apparentamene può sembrare simile come il boreout?
Il boreout si configura come una condizione di apatia e insoddisfazione dovuta non tanto al carico di lavoro, quanto piuttosto alla ripetitività eccessiva delle mansioni. Chi soffre di boreout sperimenta una noia prolungata, la sensazione di essere sottoutilizzato rispetto alle proprie competenze, di non avere compiti o sfide adeguate, di svolgere un lavoro privo di significato personale. Questo può portare a comportamenti disfunzionali come il prolungamento artificiale dei compiti, pause frequenti e non giustificate, demotivazione e, nei casi peggiori, ad ansia e sintomi depressivi derivanti dalla sensazione di una mancanza di senso nella partecipazione al contesto lavorativo.
Vediamo le principali differenze: il boreout può essere vissuto con confusione o senso di colpa riguardo alla sensazione di avere un lavoro, ma non essere in grado di trarre da esso una soddisfazione che vada al di la di quella economica, e un logoramento interno del proprio senso di sé, derivante dal fatto di non sentirsi sufficientemente riconosciuto e usato dal proprio contesto, mentre il quiet quitting è solitamente una difesa o una manifestazione di malcontento contro un contesto ritenuto incoerente o tossico.
- Una persona con mansioni povere di senso o ripetitive (boreout) può, nel tempo, decidere di disinvestire attivamente (quiet quitting).
- Al contrario, chi si sente sfruttato (quiet quitting) può arrivare a percepire il lavoro come privo di significato e cadere in boreout.
Questi fenomeni pongono una domanda centrale alla gestione delle organizzazioni che vogliano promuovere il work engagement e il buon funzionamento della propria cultura interna; esiste una quantità di “stress ottimale” gestibile nelle organizzazioni? Come si può proteggere l’investimento emotivo che i lavoratori fanno nel contesto lavorativo?
Lo stress non è solo una risposta negativa da evitare, ed esiste un livello di attivazione psicofisiologica che aiuta a costruire l’interesse per l’attività che stiamo svolgendo e ci aiuta a soddisfarci senza mandarci però in iperstimolazione e burnout.
Si parla infatti di “eustress” o stress funzionale, cioè quel livello di reazione psicofisiologica ottimale che attiva le risorse personali, stimola la crescita, aumenta il senso di autoefficacia e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi. Questo termine, introdotto dal medico e ricercatore Hans Selye, indica quella tensione positiva che ci spinge ad affrontare le sfide con energia, a restare concentrati, a dare il meglio di noi in situazioni che ci mettono alla prova, ma in modo sano e sostenibile. È lo stress che proviamo prima di un colloquio importante, durante un progetto stimolante, o quando ci troviamo a imparare qualcosa di nuovo sapendo di avere gli strumenti per riuscirci.
La differenza rispetto allo stress negativo, che Selye chiama in particolare distress, sta proprio nella percezione: l’eustress è uno stress che sentiamo di poter gestire, che ci attiva senza travolgerci. In questi casi, lo stress diventa alleato: aumenta l’attenzione, la motivazione, la creatività. E quando superiamo la sfida, ci sentiamo più competenti, più forti, più soddisfatti.
Nel contesto lavorativo, promuovere l’eustress e pervenire i fenomeni di disillusione da parte dei lavoratori significa offrire alle persone obiettivi chiari ma raggiungibili, compiti che valorizzino le loro competenze, momenti di confronto e feedback costruttivi, possibilità di crescere e imparare. In pratica: non evitare ogni fatica, ma aiutare le persone a vivere le difficoltà come opportunità di sviluppo, e non come minacce.
Un’organizzazione che sa coltivare eustress è un ambiente in cui si lavora con impegno ma anche con piacere, dove si può sbagliare senza sentirsi giudicati, e dove ogni sfida diventa un’occasione per mettersi in gioco. Non si tratta quindi di eliminare lo stress, ma di imparare a renderlo un alleato. Perché, in fondo, non è la pressione in sé a farci male, ma come la viviamo e come veniamo supportati nel gestirla.
Il delicato equilibrio tra sfida e supporto, tra autonomia e controllo, tra varietà delle mansioni e chiarezza degli obiettivi, è essenziale per promuovere un benessere lavorativo duraturo. In questo quadro, è fondamentale che le aziende adottino strategie preventive che pongano l’attenzione non solo agli eccessi di stress, ma anche alla sua carenza. Ciò significa progettare ruoli e percorsi di crescita che valorizzino le competenze individuali, assegnare compiti sfidanti ma raggiungibili, alternare attività di routine a progetti stimolanti, e fornire costantemente feedback, riconoscimenti e opportunità di formazione.
Il coinvolgimento dei dipendenti, inoltre, passa anche dalla possibilità di partecipare attivamente ai processi decisionali, di proporre soluzioni innovative, di vivere un clima di ascolto e rispetto delle esigenze personali. Occorre monitorare attentamente i segnali di scarso interesse o coinvolgimento, nonché quei comportamenti apparentemente “conformi” ma che celano una perdita di motivazione. Allo stesso tempo, la prevenzione del boreout e del quiet quitting passa attraverso politiche di conciliazione vita-lavoro, il riconoscimento delle diversità e delle differenti fasi di vita professionale, e la capacità di intervenire tempestivamente sui fattori che generano insoddisfazione strutturale.
Fonti: Puntosicuro.it, Massimo Servadio (Psicoterapeuta Sistemico relazionale e Psicologo del Lavoro e delle organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute organizzativa e Psicologia della Sicurezza lavorativa.)


